Claudio Giulio Sartori
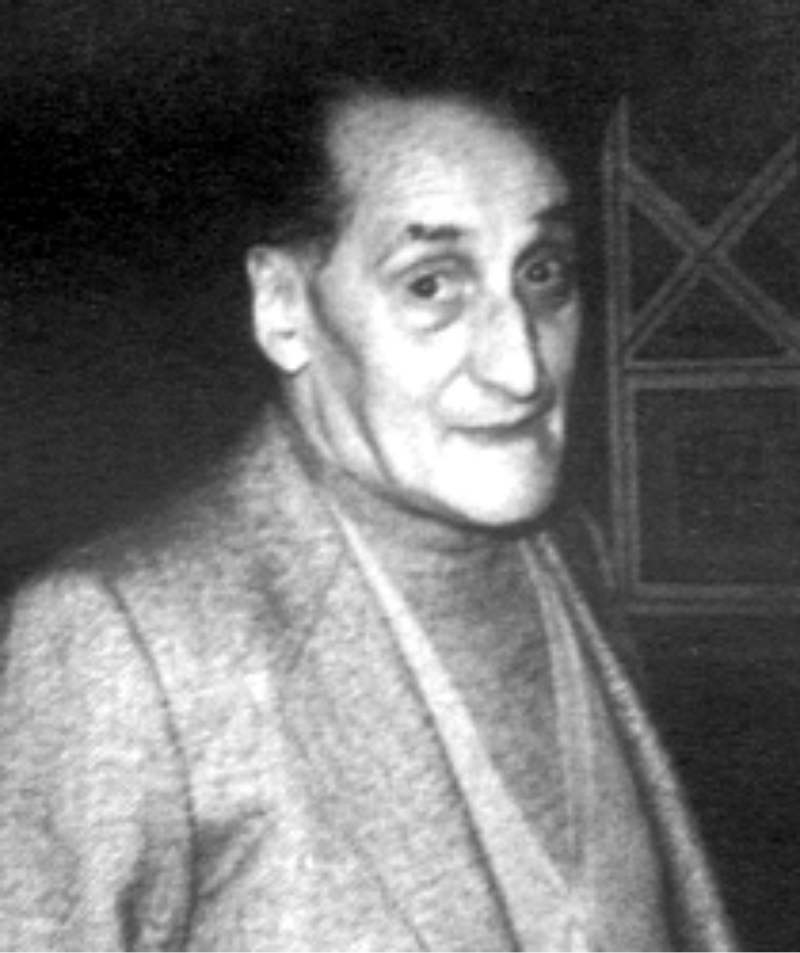
SARTORI Claudio Giulio
(Brescia, 1 aprile 1913 - Milano, 11 marzo 1994). Di Alessandro (v.), giornalista, e di Pia Treves, ebrea scrittrice. Studia pianoforte e lettere: doppia attività, come scrisse egli stesso, che caratterizza tutta la sua vita. Non "bastandogli il pianoforte" si laurea all'Università di Pavia nel 1934 con Giusto Zampieri con una tesi di storia della musica, «cosa nuova, come ricorda, per quell'epoca», ed è allievo di Franco Vittadini nel liceo musicale di quella città, prima di completare la sua formazione fuori d'Italia presso Théodore Gérold all'Università di Strasburgo. Incominciò la carriera di insegnante nel ginnasio di Orzinuovi ma dal 1939 al 1942 è vicebibliotecario del Liceo Musicale di Bologna appassionandosi allo studio delle fonti musicali e pubblicando i primi articoli di musicologia. Giacomo Benvenuti lo scopre e lo associa alla pubblicazione nel 1941-1943 dei "Classici Musicali Italiani".
Mobilitato, viene assegnato all'Ufficio della Censura del Ministero dell'Interno. L'8 settembre 1943 torna a Brescia e prende parte alla Resistenza; nel novembre è tra i primi collaboratori del periodico "Brescia Libera", del quale cura la stampa in ciclostile dopo che Franco Salvi dovette abbandonare Brescia. In seguito all'arresto il 6 gennaio di Lunardi e Margheriti, lascia con altri Brescia per Milano dove con Teresio Olivelli dà vita il 14 marzo 1944 a "Il Ribelle" sul quale firma articoli con il nome di Pierino, P., Giovanni, G., continuandone la redazione e la pubblicazione dopo l'arresto di Olivelli nell'aprile 1944. Al contempo assume il servizio di assistenza ai carcerati, alle loro famiglie e agli ebrei gestito dal Comando generale delle Fiamme Verdi e, parzialmente, quello analogo che dipendeva dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia a contatto con il gen. Luigi Masini, con Ferruccio Parri ecc. Arrestato l'8 febbraio 1945 rimane in carcere. a S. Vittore fino alla Liberazione, continuando ad animare la Resistenza.
Dopo la liberazione viene assunto come giornalista al "Popolo di Milano" diventando poi direttore del settimanale "Democrazia", organo della Democrazia Cristiana di Milano. Riprende presto anche l'attività di musicologo e, trasformato in conservatorio il Liceo Musicale di Bologna e soppresso il posto di vicebibliotecario, vi assume la cattedra di materie letterarie passando dal 1947 al 1958 alla biblioteca del Conservatorio di Milano, svolgendo per qualche tempo anche l'attività di critico musicale a "Il Popolo", al "Tempo" di Milano, a "La Patria". Abbandonata del tutto la politica "si dedica, come ha scritto François Lésure, da quel momento in poi esclusivamente alla ricerca musicologica, ritenendo che questa deve accordare un'assoluta priorità all'inventariazione delle fonti. Il Rism (Répertoire International des Sources Musicales), che prende vita proprio in quegli anni, trova in lui il più efficace dei collaboratori, in un paese dove esiste una grandissima dispersione dei documenti.
Sartori si assicura la collaborazione di decine di corrispondenti e riesce a fare, con mezzi molto ridotti, una sorprendente raccolta di dati, che presto riassume in due articoli dal titolo trionfalistico: "Finalmente svelati i misteri delle biblioteche italiane". Dal 1955 fa parte del Council dell'Associazione Internazionale delle Biblioteche Musicali (AIBM) ed è nominato membro del direttivo dell'associazione stessa. Dal 1956 al 1971 sarà anche membro del comitato di redazione di «Acta Musicologica». Passato, nel 1959, alla Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, ottiene finalmente, nel 1965, di poter realizzare con Mariangela Donà l'Ufficio Ricerca Fondi Musicali, la cui direzione egli conserva fino al momento del suo pensionamento (e oltre). Gli è affidata anche la raccolta dei dati per il repertorio internazionale della musica a stampa e manoscritta. «Centinaia di musicologi di tutti i paesi, scrive ancora il Lésure, hanno potuto e possono ottenere, grazie a questo 'cervello' delle biblioteche italiane, le informazioni bibliografiche di cui hanno bisogno, anche relativamente al diciannovesimo secolo, superando così il termine (1800) fissato dal Rism.
Tutte le informazioni che erano pervenute all'Ufficio Ricerca Fondi Musicali permisero a Sartori di mettere a segno tre importanti imprese: la bibliografia della musica strumentale italiana stampata prima del 1700 (1952-68), il Nuovo Vogel (1977) e il Catalogo dei libretti italiani a stampa (oltre 25000 schede, corredato di molti indici, (1990-4)». L'assiduo lavoro quotidiano impiegato per portare a termine questi progetti di ricerca venne interrotto solo in occasione di due incarichi d'insegnamento negli Stati Uniti: all'Università di Buffalo, per il corso invernale del 1965, e all'Università di Los Angeles, per il corso estivo del 1969.
Fu socio dell'Ateneo di Brescia e dell'Accademia Cherubini di Firenze. «Abilissimo, come ha scritto il Lésure, nella ricerca d'archivio: dal 1950 esplora i fondi dell'archivio del duomo di Milano, nell'intento di scrivere la storia documentaria di quell'istituzione; riesce a mettere insieme una quantità straordinaria di dati archivistici che vanno da Matteo da Perugia a Johann Christian Bach, passando per Monteverdi, Franchino Gaffurio e, soprattutto, Josquin Desprez». E ancora, lo stesso Lésure, scrive «l'enorme Catalogo dei libretti italiani, che ha raggiunto il traguardo della pubblicazione, rende palese la somma impressionante di strumenti di lavoro realizzata da un solo uomo, come effetto unicamente della sua energia e, se posso dire così, del suo pessimismo costruttivo».
OPERE:
"La notazione italiana del '300 in una redazione inedita del «Tractatus practice cantus mensurabilis ad modum Italicorum» di Prosdocimo de Beldemandis" Firenze, 1938);
"Il R. Conservatorio «G.B. Martini» di Bologna" (Le Monnier, Firenze, 1942); "Bibliografia delle opere musicali stampate da Ottaviano Petrucci, Olschki, Firenze 1948 (e Nuove conclusive aggiunte alla bibliografia del Petrucci in «Collectanea historiae musicae»" (vol. 1°, Olschki, Firenze, 1953, pp. 175-210); "La manna di S. Vittore" (La Scuola, Brescia, 1952); "Bibliografia della musica strumentale italiana stampata in Italia fino al 1700" prefazione di Alfred Einstein (Olschki, Firenze, 1952, che si completa con "Bibliografia della musica strumentale italiana stampata in Italia fino al 1700: volume 2° di aggiunte e correzioni con nuovi indici", Olschki, Firenze, 1968); "Monteverdi" (La Scuola, Brescia, 1953); "Riccardo Malipiero (English Translation by Reginald Smith-Brindle)" (Suvini Zerboni, Milano, 1957; ristampato in Claudio Sartori - Piero Santi, "Due tempi di Riccardo Suvini Zerboni, Milano, 1964); "La cappella musicale del duomo di Milano: catalogo delle musiche dell'archivio" (Fabbrica del Duomo, Milano, 1957); "Dizionario degli editori musicali italiani (tipografi, incisori, librai-editori)" (Olschki, Firenze, 1958); "Puccini" (Nuova Accademia, Milano, 1958; Accademia, Milano, 1978); "Casa Ricordi, 1808-1858" (Ricordi, Milano, 1958); "Giacomo Puccini (a cura di Claudio Sartori). Saggi di vari autori. Catalogo delle opere, letteratura" (Ricordi, Milano, 1959); "Giacomo Puccini a Monza" (Università Popolare, Famiglia Artistica, Pro Cultura, Monza, 1958); "Dizionario Ricordi della Musica e dei Musicisti" (Ricordi, Milano, 1959, con Fausto Broussard e altri); "Assisi. La cappella della basilica di S. Francesco. Catalogo del fondo musicale nella Biblioteca Comunale di Assisi" (Istituto Editoriale Italiano, Milano, 1962); "Enciclopedia della Musica diretta da Claudio Sartori" (4 voll., Ricordi, Milano, 1963-4); "Commemorazione di Ottaviano de' Petrucci" (Città di Fossombrone, Fossombrone, 1966); "Quartetto milanese ottocentesco: lettere di Giuseppe Verdi, Giuseppina Strepponi, Clara Maffei e Carlo Tenca" (Archivi Edizioni, Roma, 1974, con lo pseudonimo Arturo Di Ascoli); "Giacomo Carissimi: catalogo delle opere attribuite" (Finarte, Milano, 1975); "Bibliografia della musica italiana vocale profana pubblicata dal 1500 al 1700. Nuova edizione interamente rifatta e aumentata [Nuovo Vogel]" (3 vol., Staderini-Minkoff, Pomezia Genève, 1977, con François Lésure); "L'avventura del violino: l'Italia musicale dell'Ottocento nella biografia e nei carteggi di Antonio Bazzini" (Eri, Torino, 1978); "Ostiglia. La biblioteca dell'Opera Pia Greggiati. Catalogo, vol. I. Le edizioni" (Nuovo Istituto Editoriale Italiano, Milano, 1983); "I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800: catalogo analitico con 16 indici" (7 voll., Bertola e Locatelli, Cuneo, 1990-4). Ha collaborato a numerose pubblicazioni periodiche specializzate e divulgazioni fra le quali: "Archivum Romanicum", "Musica d'Oggi", "Rivista Musicale Italiana-, "La Rassegna Musicale", "Rossiniana", Bibliofilia", "Fontes Artis Musicae", "La Scala", "Tempo e Musica", "Acta Musicologica", "Nuova Rivista Musicale", "Quaderni Pucciniani", "Opera" e a molte altre.
Ha collaborato con numerose voci a dizionari ed enciclopedie musicali fra le quali "Die Musik in Geschichte und Gegenwart", "Larousse de la Musique", "Enciclopedia dello Spettacolo", "Encyclopédie de la Musique", "De Algemene Muszick-Encyclopedie" "Dictionnaire de la Musique", "Grove", "Dizionario Enciclopedico Universale della Musica UTET", "La Musica".
Specificatamente su ARGOMENTI BRESCIANI ha pubblicato i seguenti articoli: "Antonio Bazzini negli ultimi anni" («Brescia», XIV 1936, p. 17); "Uno studio del musicista Chimeri sul musicista Quaranta" («Commentari dell'Ateneo di Brescia per il 1936», 1937, pp. 69-117); "La prima dell'«Otello» a Brescia, 10 agosto 1887" (Teatro Grande, Brescia, Stagione lirica febbraio 1938, pp. 23-7); "Franco Faccio e venti anni di spettacoli di fiera al Teatro Grande di Brescia: carteggi e documenti inediti" («Rivista Musicale Italiana», XLII 1939, pp. 544-68); "Musica in un quadro del Savoldo" («Rivista Musicale Italiana», XLIII 1939, pp. 544-568); "Giacomo Benvenuti" («Rivista Musicale Italiana», XLVIII 1943, pp. 87-90); "I compagni di Olivelli" e "Breve storia di un giornale clandestino" in A. Caracciolo, «Teresio Olivelli» (La Scuola ed. Brescia, 1947, pp. 179-203); "Giulio Monteverdi a Salò" in «Nuova Rivista Musicale Italiana», I 1967, pp. 685-696); "Orazio Vecchi e Tiburzio Massaino a Salò: nuovi documenti inediti, in Renaissance-Muziek, 1400-1600. Donum natalicum René Bernard Lenaerts" (onder redactie van Jozef Robijns, katolieke Universiteit, Leuven, 1969, pp. 233-40); "Quisquilie pucciniane e intuizioni bazziniane" («Nuova Rivista Musicale Italiana», VIII 1974, pp. 366-70); "Antonio Bazzini e i suoi maestri" («Nuova Rivista Musicale Italiana», XI 1977, pp. 606-21); "Antonio Bazzini e il teatro lirico, in Il melodramma italiano nell'Ottocento. Studi e ricerche per Massimo Mila" (a c. di Giorgio Pestelli, Einaudi, Torino, 1977, pp. 437-49).
TRADUZIONI: Robert Schmitz, "Il pianoforte di Claude Debussy" (edizione originale The Piano Works of Claude Debussy, ed. and designed by Merle Armitage, Duell Sloan and Pearce Publishers, New York, 1950; Aldo Martello, Milano, 1952); Marcel Brion, "Schumann e l'anima romantica" (edizione originale Schumann ou l'áme romantique, Mursia, Milano, 1958; Sirio. Biografie e ritratti, 8); François Lésure, "Musica e società" (Istituto Editoriale Italiano, Milano, 1966).
EB – Enciclopedia Bresciana di Antonio Fappani
Fondazione Civilità Bresciana
Brescia
www.enciclopediabresciana.it
